
La tempesta nel bicchiere d’acqua di Erdogan
Che le relazioni internazionali potessero essere talvolta affini alle commedie degli equivoci è cosa nota. Che i loro canovacci potessero essere a così facile portata di mano un po’ meno, anche per quanto riguarda gli aspetti paradossali che essi stessi sottendono. La tempesta nel bicchiere d’acqua (del Bosforo) che ha visto contrapposti il Presidente Erdogan e 10 ambasciatori occidentali è durata il tempo di un battito d’ali di farfalla. Un battito che ha comunque vibrato fin nell’altro emisfero.
In conclusione, mentre chi era detenuto è rimasto tale, i diplomatici minacciati di allontanamento sono rimasti presso le loro legazioni, lasciando sullo sfondo la scenografia di un brevissimo atto unico ad uso interno, che ha visto protagonista il Presidente Erdogan. Quest’ultimo ulteriormente indebolito dalle accuse di corruzione diffuse dal boss della malavita in esilio Sedat Peker. È dal 2019 che la leadership anatolica, pungolata dalla persistente questione curda, si è avventurata su una perigliosa serie di iniziative politico-militari che, sconfitta armena nel Nagorno Karabakh a parte, hanno fruttato molto poco. Le attività condotte in Mediterraneo Orientale, in Libia, a Kabul passando per Idlib, hanno reso Ankara sia diplomaticamente più isolata che mai, sia soggetta alle insostenibili ondate migratorie dei rifugiati afghani e siriani.
La situazione turca
Mentre l’economia affonda ed il Financial Action Task Force (Organismo di controllo finanziario globale con sede a Parigi) inserisce la Turchia nella lista grigia dei paesi soggetti a un maggiore controllo su finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e corruzione istituzionale, mentre l’Occidente si allontana, c’è chi inizia a chiedersi se non sia finita un’era, quella dell’AKP destinato, a meno di non impossibili colpi di coda(L’Akp e il suo alleato di governo, Mhp guidato da Devlet Bahceli, si sono accordati per abbassare dal 10 al 7% la soglia di sbarramento per l’accesso parlamentare. La proposta è dettata dalla necessità di assicurare all’Mhp, che assicura la maggioranza, la partecipazione alla prossima legislatura), ad una transizione politica incerta.

Le prossime elezioni potrebbero tramutare il 2023 in un annus horribilis per il Reis che, ancora sensibile per i deludenti risultati elettorali delle amministrative del 2019 dovrà affrontare, o lasciare in eredità, la riforma di 4 elementi statuali fondanti. C’è l’architettura politica di un sistema super presidenziale che agevola il leader del momento ma rende facile individuare il responsabile degli insuccessi, stato di diritto, economia, difesa. Oltre al verticismo istituzionale esasperato, alle critiche mosse verso la magistratura, la Turchia, che ha bisogno di investimenti esteri diretti che esigono fiducia nel management monetario e fiscale interni, si distingue per la politica tenuta sui tassi di interesse, basata sul convincimento che le banche non debbano addebitarne, e che tassi contenuti determinino una bassa inflazione.
Dal punto di vista internazionale, ed a beneficio russo, la Turchia ha interpretato il ruolo del cuneo con la Nato, e ha portato ad un’impasse sul sistema missilistico russo S-400 che ha indebolito le forze aeree turche, e ha bloccato qualsiasi rapporto utile a dirimere la questione inerente alla fornitura degli F-35 statunitensi. Il repentino annuncio dell’intenzione di allontanare i 10 diplomatici ha poi provocato un ulteriore e grave contraccolpo sullo stato della tenuta del mercato finanziario, già messo a dura prova da un taglio del suo tasso di riferimento di 200 punti base, foriero di rinnovate turbolenze.
Il problema economico
Prendendo a paradigma il programma economico governativo a medio termine, gli osservatori sono giunti ad una duplice conclusione: da un lato si sostiene che Ankara stia scientemente procedendo ad una svalutazione controllata della moneta, dall’altro si ritiene che la Turchia sia ormai così prostrata, con un abbassamento dei tassi che non stimola la crescita economica, da non poter che mettere una pietra tombale su uno dei leit motiv populistico economici dell’AKP.
Provvedimenti adottati: l’allontanamento di tre membri del comitato di politica monetaria, che non ha tuttavia potuto evitare il rischio di fuga degli investimenti esteri con riserve valutarie troppo basse per ipotizzare interventi sul mercato. A poco vale il principio di un deprezzamento volto ad agevolare le esportazioni, visto che permane una forte dipendenza dai fattori produttivi importati, cui si è aggiunto un aggravamento dei costi energetici, interessati peraltro alle vicende relative ai gasdotti provenienti dall’est russo.

La crescita del 1° trimestre dell’anno, basata sull’aumento dei consumi, ha comunque minato la stabilità monetaria con svalutazione ed inflazione, contribuendo ad accentuare una volatilità capace di inficiare i temporanei miglioramenti conseguiti. Di fatto la Banca Centrale, soggiacendo alla volontà politica, ha ceduto quota parte della sua autonomia, e ha alimentato la disaffezione nei confronti della maggioranza al potere, di cui socialmente si condivide sempre meno la tendenza alla politica di proiezione nei teatri di crisi. Sintesi: prezzi alle stelle, perdita del potere d’acquisto da parte del ceto medio, malcontento serpeggiante. E costante necessità di ricorrere ad armi di distrazione di massa, come il minacciato allontanamento dei 10 diplomatici.
Neanche i rapporti con le Forze Armate sono agevoli; 10 ammiragli in pensione (Tra i militari fermati troviamo l’ammiraglio Cem Gurdeniz, esponente della corrente euroasiatica scettica verso la Nato e aperta a Russia e Cina a est, e teorico della dottrina della ‘Patria Blu’, impiegata proprio da Erdogan per sostenere le sue ambizioni espansionistiche nei confronti di Grecia e Cipro.), contrari al Canale di Istanbul, che porterebbe ad affrontare i rischi di un ritiro dalla Convenzione di Montreux, firmata nel 1936 per regolare il traffico navale negli stretti turchi, sono incorsi nelle ire di un governo suscettibile alla minima obiezione; un progetto criticato da pochi e rari illuminati per via di un’esposizione economica che presterebbe il fianco ad interessati finanziatori stranieri come Cina e Qatar.
La domanda è spontanea: quali sono gli oggetti più o meno oscuri e proibiti dei desideri di Erdogan?
Al di là della conquista del ruolo di leader della complessa galassia sunnita secondo il modello ottomano, rimane la suasion esercitata dalla Fratellanza Musulmana e dai suoi sostenitori qatarini, che lo hanno blandito con l’inconsistente granularità delle Primavere Arabe, e la necessità fisiologica di garantire una presenza internazionale che giustifichi il suo esistere politico. In un certo qual modo Erdogan rappresenta il potere che divora sé stesso, l’autocrate che ha bisogno del permanere di ondivaghi e fluttuanti stati di crisi per giustificare sé stesso prima sul palcoscenico nazionale, e poi sul proscenio internazionale.
La scenografia occidentale, in particolare, rimane ostica; oltre ai già richiamati e problematici aspetti logistico operativi inerenti alle Forze Armate, prima il riconoscimento da parte USA (Definiti dal ministro della Difesa Hakar “un alleato strategico”) del genocidio armeno del 1915, da sempre oggetto del negazionismo turco, poi la gestione ad uso interno del grottesco sofagate con la Presidente della Commissione UE, hanno evidenziato come la leadership ancirana, sull’orlo di una crisi di nervi, reagisca alle pressioni cui è sottoposta, e come stia offrendo degli assist preziosi all’opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu, attaccato per la fede alawita.
Se Washington intende servirsi del riconoscimento degli eventi armeni per redarguire e mettere all’angolo un alleato recalcitrante, volto più ad est che a ovest e punto con lo spillo della tutela dei diritti umani in un momento di debolezza interna economica ed in un contesto sociale che non ha dimenticato gli eventi di Gezi Park, la danza delle poltrone con i vertici politici europei può indicare una goffa volontà ritorsiva tuttavia fiaccata dall’ennesima dilazione continentale per l’accoglimento di Ankara nel consesso politico di un Mondo sì Vecchio, ma ancora sensibile ad una troppo pronunciata assertività anatolica.
La “morale” europea
Un campanello d’allarme da non sottovalutare, vista la determinazione francese nell’assumere prese di posizione forti, e l’inedita pro-attività diplomatica tedesca, abitualmente portata alla moderazione ed al calcolo pragmatico finalizzato al ricavo delle vendite dei sistemi d’arma ed al contenimento delle ondate di profughi. Al netto delle considerazioni su chi abbia o meno sottoscritto l’appello pro Kavala, rimane l’alea di una morale europea a geometria variabile, non sempre così inappuntabile e legata ad interessi di notevole entità.
Sipario dunque su prologo ed atto unico della kafkiana querelle Kavala (Imprenditore turco, arrestato nell’ottobre 2017 con accuse pretestuose relative al fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 ed alle proteste antigovernative del 2013. Kavala è stato accusato anche di spionaggio.), filantropo detenuto da anni senza aver subito condanne, che non intende partecipare ai dibattimenti data l’impossibilità di godere di un processo equo, e per la scarcerazione del quale ben 10 ambasciatori occidentali (USA, Canada, Germania, Francia, Olanda, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Nuova Zelanda) hanno sottoscritto un appello, ricevendone un non gradimento in forma esclusivamente verbale, prodromico ad ipotetiche espulsioni di massa, secondo ispirazioni estemporanee evidentemente non curanti delle conseguenze, quali la rottura delle relazioni diplomatiche, non escluse dalla convenzione di Vienna.
Sembra evidente che vi siano forti spinte interne all’area di governo, in cui si scontrano due vettori politici: il blocco nazionalista che vuole separarsi da NATO ed Occidente, e quello democratico e filoccidentale che ritiene che la Turchia debba continuare a guardare ad Ovest. Dato lo sconcerto istituzionale venutosi a determinare, o Erdoğan ha proceduto a queste dichiarazioni senza un’adeguata riflessione, oppure questo altro non è che il primo passo verso un processo politico ponderato in previsione delle elezioni del 2023 che potrebbero essere anticipate. Conclusioni pubbliche.
Erdogan, una volta che i Paesi coinvolti hanno diffuso un comunicato con cui hanno ribadito l’impegno a non interferire negli affari interni di un paese ospitante le proprie legazioni, ha fatto intendere di aver optato per un percorso a ritroso piuttosto lungo. Conclusioni geopolitiche. Erdogan non può prescindere da un’Europa a due velocità diplomatiche: non è la prima volta che l’Italia, per esempio, si oppone all’irrogazione di sanzioni contro la Turchia. In un certo qual modo, la leadership turca, che cerca comunque di compiacere gli europei, punta su un orgoglio utile nei frangenti di debolezza, ma che denota una un’involuzione politica da decifrare, e che si inquadra in un contesto internazionale dove il sistema di equilibrio di potere appare ancora instabile.
In un momento di debolezza interna, con l’attrito a più alto livello tra anglosfera e Cina Erdogan, secondo un metro di giudizio scientifico e non di valore, si palesa quale uomo forte di stampo arcaico, propugnatore di forme conservatrici tuttavia vincolate a visioni politiche d’altri tempi. Tenuto conto degli eventi e delle prospettive elettorali del 2023, c’è solo da chiedersi se il Reis non sia già da ora in ansiosa attesa nel miglio verde della politica turca.




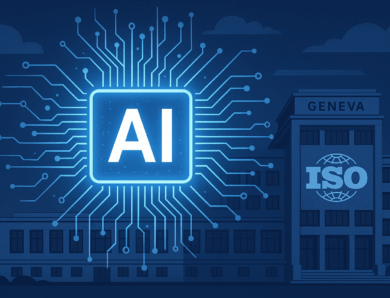

No Comment