
Oltre “somma zero”: Ginevra e l’emergenza Covid-19
La pandemia legata al virus Covid-19, con oltre 228 milioni di casi confermati nel mondo e 4 milioni 690 mila 166 morti (dati OMS del 20 settembre 2021), lo sconvolgimento della vita quotidiana della maggior parte degli abitanti del pianeta ed effetti economici devastanti – solo in parte alleviati, ed in un numero limitato di Paesi, dagli interventi pubblici a sostegno di cittadini ed imprese – può senza dubbio essere classificata tra gli eventi tragici della storia moderna e contemporanea.
Partendo dalla triste constatazione che i progressi più significativi nell’ambito delle relazioni internazionali sono spesso avvenuti dopo grandi tragedie (basti pensare alla creazione delle Nazioni Unite dopo il secondo conflitto mondiale o a quella dei Tribunali penali internazionali (per la ex-Jugoslavia, per il Ruanda fino alla Corte penale internazionale) dopo genocidi che hanno scosso profondamente le coscienze, istituzioni che nonostante limiti di autonomia e di intervento hanno facilitato notevolmente la cooperazione tra Stati sovrani e il perseguimento di crimini gravi ), è lecito chiedersi se l’attuale pandemia possa anch’essa determinare un’evoluzione strutturale nei rapporti tra gli attori della comunità internazionale, siano essi Stati, organismi inter governativi o non governativi.
Domanda rilevante per uno dei centri della governance mondiale come Ginevra.
La città che ospita la sede europea delle Nazioni Unite, 36 organizzazioni internazionali, circa 700 organizzazioni non governative e 179 missioni diplomatiche.
Qualche segnale incoraggiante può essere individuato all’interno di singoli Stati e realtà regionali. Il virus ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare il ruolo del settore pubblico come motore di investimenti produttivi (si veda al riguardo il fondo “Next Generation EU” che rappresenta una prima forma di mutualizzazione del debito tra i Paesi dell’Unione europea), e come attore di rilievo in ambiti ridivenuti strategici come la sanità. La pandemia ha inoltre accelerato il dibattito intorno al tema della sostenibilità, che coinvolge anche imprese e cittadini-consumatori, con l’obiettivo di concepire un nuovo paradigma di sviluppo che concili crescita economica, rispetto dell’ambiente e valorizzazione delle persone. Eliminando progressivamente ogni forma di sfruttamento e discriminazioni.
Ma se il numero di Paesi interessato da tali processi è ancora limitato, il dato scoraggiante rispetto all’ipotesi di un’evoluzione delle relazioni internazionali nel senso di una maggiore collaborazione, è un altro. Guardando, infatti, la natura profonda dei rapporti tra Stati sovrani, nulla sembra ancora essere cambiato nel “gioco a somma zero” che li caratterizza. Al contrario, la pandemia sembra aver esacerbato il conflitto tra quelli che Alessandro Aresu definisce le due versioni attualmente più efficaci del “capitalismo politico”, vale a dire Stati Uniti e Cina. “Diplomazia dei vaccini” come strumento di consolidamento o espansione delle rispettive “sfere di influenza”, competizione tecnologica per la supremazia in settori chiave (intelligenza artificiale), commerciale (terre rare) e militare (recente conclusione dell’AUKUS in funzione anticinese). Con l’Unione europea alla ricerca di un suo status internazionale nel delicato equilibrio tra maggiore integrazione e prerogative degli Stati membri e la Russia impegnata nel difficile tentativo di mantenere una qualche rilevanza internazionale in uno scenario che, per forze in campo, si delinea sempre più come un “G2” Stati Uniti – Cina.
Nulla di nuovo sotto il sole, dunque? Sembrerebbe così. Se proviamo però a guardare un altro aspetto della pandemia, forse delle ragioni per una qualche dose di ottimismo rispetto all’avanzamento del dialogo e della cooperazione internazionale possono essere trovate.
Uscire dall’emergenza Covid

L’uscita dall’emergenza, infatti, secondo la “road map” indicata dall’OMS, passa inevitabilmente dalla vaccinazione con doppia dose di almeno il 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022. L’urgenza è dovuta al fatto che, malgrado non vi sia certezza scientifica al riguardo, la circolazione del virus può generare varianti progressivamente più aggressive, che possono nel tempo mettere a rischio anche quegli Stati dove le campagne di vaccinazione hanno già raggiunto gli obiettivi prestabiliti. Le conseguenze economiche e sociali di un prolungamento sine die dell’emergenza sanitaria su scala mondiale sarebbero catastrofiche.
Vaccinare il 70% della popolazione mondiale non comporta soltanto la fabbricazione e la distribuzione di vaccini anti covid-19 a tutti quei Paesi che non possono pagarne i costi ma anche un aiuto in termini di logistica per realizzare campagne vaccinali su vasta scala. Al 20 settembre, infatti, se molti Paesi dell’emisfero nord registrano percentuali di vaccinati con seconda dose vicine se non superiori all’80% della popolazione. Paesi come il Mali, il Chad ed il Madagascar, solo per citarne alcuni, sono ancora sotto la soglia dell’1%. Difficile pensare di raggiungere in tempi ragionevoli percentuali vicine al 70% senza un aiuto anche logistico da parte comunità internazionale.
L’importanza del Covax per la lotta al Covid
Ecco che se gli Stati più influenti del pianeta mettessero in atto strumenti efficaci di cooperazione internazionale volti ad aiutare i Paesi più bisognosi a raggiungere gli obiettivi di vaccinazione stabiliti dall’OMS, senza necessariamente l’obiettivo più o meno celato di avvicinarli alle proprie posizioni geopolitiche. In altre parole, a non interpretare rispetto alla pandemia le relazioni internazionali come un “gioco a somma zero”, allora si saranno poste le basi per un’evoluzione storica delle relazioni internazionali. Si potrebbe dunque, intravedere un nuovo modus operandi della governance mondiale, che potrebbe estendersi anche ad altri ambiti dove è fondamentale pensare la logica del beneficio in termini di “Pianeta” invece che di singolo Stato per avere una qualche chance di successo, come ad esempio i negoziati ambientali nell’ambito della 26° Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26).
Se sarà così, e credo sia interesse di tutti sperarlo, Ginevra potrebbe vedere presto consolidato il proprio ruolo di centro mondiale del dialogo e della cooperazione. Con istituzioni come l’OMS, l’OMC, l’UNEP e tutte quelle iniziative innovative – come il COVAX – che promuovono la cooperazione tra settore pubblico e privato su scala mondiale, che vedrebbero accresciute la propria rilevanza e possibilità di impatto nel gioco non più esclusivamente a “somma zero” delle relazioni internazionali.
Massimo Vittori
Massimo Vittori è direttore di oriGIn, un’organizzazione non governativa con sede a Ginevra che si occupa di indicazioni geografiche, commercio internazionale e sostenibilità. Dopo la laurea in relazioni internazionali e un master in diritto internazionale, Massimo ha lavorato presso diverse organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite. È appassionato di letteratura, musica e sport.


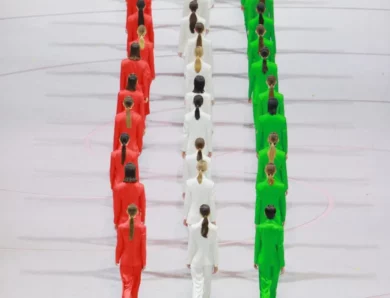



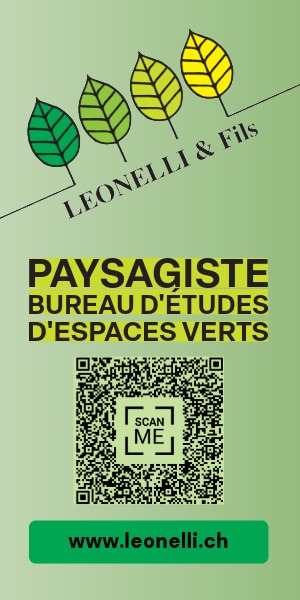
No Comment