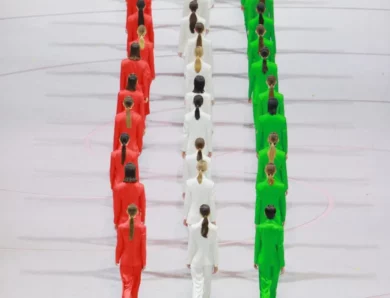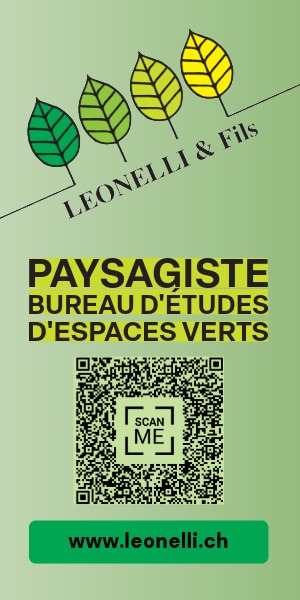Ottant’anni di Nazioni Unite: tra crisi di legittimità e necessità di riforma
Mentre si riunisce questa settimana, dal 22 al 30 settembre, l’ottantesima Assemblea Generale dell’ONU, è inevitabile riflettere sul futuro di un’organizzazione che presenta molte ombre e qualche luce.
Il 24 ottobre 2025 le Nazioni Unite celebreranno l’ottantesimo anniversario della loro fondazione. La Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco da cinquanta Stati, entrò in vigore con l’obiettivo di preservare la pace e la sicurezza internazionale, promuovere i diritti umani, sostenere lo sviluppo e favorire la cooperazione tra i popoli.
A otto decenni di distanza, il bilancio è inevitabilmente ambivalente. Da un lato, l’ONU non è riuscita a impedire la proliferazione dei conflitti armati: oggi le guerre attive superano quelle di vent’anni fa. Grandi scenari di crisi, dalla Siria all’Ucraina fino al Medio Oriente, mostrano l’impotenza di un Consiglio di Sicurezza paralizzato dall’uso del veto dei membri permanenti. L’assetto istituzionale continua a riflettere l’equilibrio di potere del 1945, risultando sempre meno rappresentativo della realtà geopolitica attuale. A questo si somma una struttura burocratica spesso lenta, inadeguata a rispondere a emergenze che richiedono tempestività.
Le luci di un’istituzione ancora indispensabile
Valutare l’ONU solo attraverso le sue mancanze sarebbe però riduttivo. Nel corso della sua storia l’Organizzazione ha fornito un quadro normativo universale grazie alla Dichiarazione universale dei diritti umani e a numerose convenzioni internazionali. Ha accompagnato i processi di decolonizzazione e ha contribuito a fissare standard comuni in settori cruciali come l’ambiente, la salute e lo sviluppo sostenibile.
Le agenzie specializzate – dall’UNICEF all’UNHCR, fino al Programma alimentare mondiale – offrono ogni giorno sostegno vitale a milioni di persone. Le missioni di peacekeeping, pur con esiti diseguali, hanno aiutato a ridurre la violenza e a stabilizzare aree altrimenti ingovernabili.

La sfida della riforma
La questione centrale riguarda il futuro. Il sistema internazionale del XXI secolo è caratterizzato dal ritorno della competizione tra grandi potenze, dall’emergere di nuovi attori regionali e transnazionali e dall’urgenza di affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, le pandemie e le migrazioni. In questo scenario un’ONU immobile rischia l’irrilevanza.
È quindi necessaria una riforma profonda: il Consiglio di Sicurezza deve diventare più rappresentativo, i processi decisionali più efficienti e i meccanismi di finanziamento più equi e stabili. Riformare l’ONU è tuttavia complesso, perché significa ridefinire equilibri di potere mondiali, con inevitabili resistenze da parte degli attori dominanti.
Un paraurti imperfetto ma insostituibile
Rinunciare all’ONU equivarrebbe però a privarsi dell’unico foro multilaterale universale, dove anche Stati rivali possono mantenere un canale di dialogo. L’immagine del “paraurti” resta valida: l’ONU non elimina i conflitti, ma ne attenua gli impatti, offrendo spazi di negoziato e strumenti di mitigazione.
Ottant’anni dopo San Francisco, le Nazioni Unite appaiono dunque insieme fragili e indispensabili. L’alternativa non è tra un’ONU perfetta e la sua abolizione, ma tra un’ONU riformata e un mondo privo di quel minimo di ordine multilaterale che, pur imperfetto, costituisce ancora il miglior argine al disordine globale.