
Quando il bambino era bambino
Quando il bambino era bambino,
se ne andava a braccia appese.
Voleva che il ruscello fosse un fiume,
il fiume un torrente;
e questa pozza, il mare.
Quando il bambino era bambino,
non sapeva d’essere un bambino.
Per lui tutto aveva un’anima,
e tutte le anime erano tutt’uno.
Quando il bambino era bambino,
su niente aveva un’opinione.
Non aveva abitudini.
Sedeva spesso a gambe incrociate,
e di colpo sgusciava via.
Aveva un vortice tra i capelli,
e non faceva facce da fotografo.
Così inizia, con i versi di Peter Handke (premio Nobel per la letteratura 2019), il film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders.
Un film in cui i protagonisti sono angeli: ascoltano i pensieri degli uomini, li registrano. Sono per le strade, nelle metropolitane, nelle biblioteche, nelle case, ovunque. È il loro compito: ascoltare ma non agire. Se intervenissero nella vita degli uomini, infatti, diventerebbero umani a loro volta. Non tutti gli angeli, però, riescono a obbedire: alcuni hanno un “cuore selvaggio”- ciò «che porta a fare esperienza dell’oltre» (Pugno, 2018) – destinato a cancellare il bianco canonico delle ali.
Nel finale di un altro film, “Cuore selvaggio” firmato David Lynch (film che, premiato a Cannes nel 1990, divise drasticamente la critica), l’inquadratura sul finale ci mostra un uomo a terra, sull’asfalto: sembra tutto finito. È stato punito, ha perso quello che doveva perdere, ma una fatina vestita da maga buona del lontano mondo di Oz arriva da lui e risplende. La sua bacchetta magica, sospesa nel cielo-cielo, non ha molto da fare, ma di certo ha qualcosa da dire: «Se davvero hai un cuore selvaggio lotterai per i tuoi sogni».
In questo periodo ci si interroga spesso su quale sia il senso della poesia, dell’arte e una risposta, univoca, non sembra esserci. Le due immagini appena descritte, tuttavia, mi scorrono davanti come piccole tracce da seguire.
Raccontano una sconfitta, una perdita? Anche. Potrebbero entrambe concludersi con i versi di “L’angelo caduto” di Rafael Alberti: «Eppure io ero, guardatemi». Potremmo ripiegarci così, ignorare la fatina buona e restare con il volto tumefatto sull’asfalto oppure continuare, e non sarebbe comunque poco, ad ascoltare quello che abbiamo attorno ignorando però ciò che batte senza ordine in noi. Sarebbe comunque arte? Potrebbe, ma con un riserbo che alla lunga rischierebbe di logorare: dovremmo iniziare a fare «facce da fotografo».
Ma cosa significa?
Maria Lai, tra le più importanti artiste italiane, in una sua opera intitolata “Legarsi alla montagna” ha lavorato partendo da una leggenda al cui centro c’è una bambina – che, con ogni probabilità, ignorava di essere una bambina. Così si racconta: «[La bambina] salì sulla montagna. Nella bisaccia aveva il pane appena sfornato da portare ai pastori, bloccati da un temporale. Dopo una lunga camminata li trovò, al riparo in una grotta con il loro bestiame. Fuori pioveva, c’erano vento e lampi. La piccola consegnò agli uomini il pane preparato dalle donne. Guardò all’esterno e vide un nastro celeste trasportato dal vento. I pastori cercarono di trattenerla: non è niente, sarà un fulmine, dissero senza darle troppa importanza. Ma la bambina corse fuori alla ricerca del nastro. In quel momento la grotta franò seppellendo pastori e bestiame». Il nastro, il filo, afferma Lai in un’intervista, rappresenta l’inaspettato, il senso dell’arte. L’artista ha così intrecciato con un filo celeste il bordo di una montagna, per chilometri: se quel nastro ha portato fuori la bambina, in salvo, chissà che non possa condurre anche noi oltre la frana e che, legandoci insieme, non possa farci vedere oltre di noi.
Cosa poi ci aspetti fuori, una volta alzati, una volta perse le ali, una volta che il crollo è avvenuto, non è così importante se davvero abbiamo appreso il movimento.
Proprio la ricerca di questo movimento ci ha guidato, nonostante il tempo che stiamo affrontando, nell’organizzazione della settimana della lingua italiana, quest’anno dedicata al rapporto tra letteratura e arte. Mia Lecomte, Francesca Serra, Samuele Fioravanti, Andrea Rivola, Martin Rueff – per citare solo alcuni dei nostri ospiti- con le loro opere e visioni hanno mostrato come ciascun linguaggio, al di là del genere e del tempo, concorra a tessere e a intrecciare un nastro celeste e il suo inseguimento. Quando questo accade, viene da pensare all’arte come a un cuore selvaggio, un vortice tra i capelli, un filo che tiene la montagna: talmente “inaspettata” da essere di tutti.


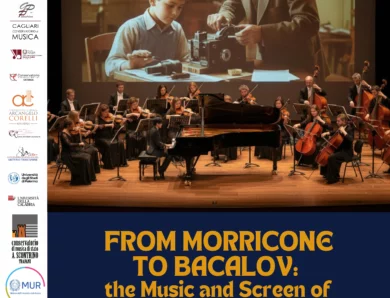

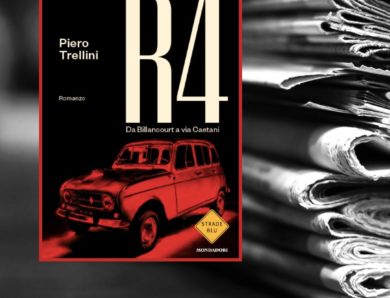

No Comment